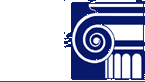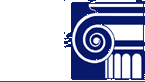Il titolo dell’intervento di Morin, apparentemente complesso, perché nulla è facile all’interno di Morin e perché altrimenti non avrebbe chiamato il suo sistema complessità, è: la riforma del pensiero e della vita per il pieno impiego della cittadinanza partecipativa.
Parole che hanno pieno impiego anche nel linguaggio socio-culturale.
Il mio intervento è di avvicinamento e di socializzazione al suo pensiero ed al suo modello di vita. Prendo due temi da sviluppare con voi:
1°cercare di mettere in scena Morin comunque ci sia possibile. Non usarlo, ma metterlo al centro di un modo di riflessione, di pensiero, di studio di un pensiero davvero singolare.
2° due o tre segni di partecipazione al recente sviluppo, intendendo l’ultimo quindicennio, del suo pensiero, senza nessun intento filologico, ma col solo intento di mettere in evidenza due o tre parole chiave che sono direttamente capaci di interloquire, valorizzare, dispensare, come un seminario che fa del territorio il proprio terreno di riflessione.
Morin in scena
Questo convegno fa del territorio, quindi del modo in cui le persone abitano il loro territorio, il proprio terreno di direzione e di riflessione. Poi chiuderò con un paio di gesti dedicatori, perché non si può che finire con le dediche.
A tutti noi può essere capitata l’occasione di studiare Morin all’università, a qualcuno è capitato addirittura di doverlo studiare in francese al liceo. Noi lo abbiamo scoperto come studioso di comunicazione, anche se adesso lui cerca di snobbare queste cose e considera la comunicazione un territorio selettivo e ormai un po’ superato nel suo sistema di pensiero. Questo apparirà dal mio dire, ma è bene che i presenti sappiano che Morin è stato il primo studioso europeo ad essersi occupato scientificamente di comunicazione.
La copertura culturale dei media, cioè il fatto che i media siano diventati un terreno di studio, di valorizzazione scientifica e persino una tribù di studiosi, una comunità, è incredibile a dirsi ma rimanda a questo signore che ho accanto. Non ci sarebbero studi di comunicazione in Europa senza Morin.
Siamo di fronte a un fondatore e ci vorrebbe un minuto di silenzio come riconoscimento che lui sia socio fondatore del nostro campo di studi. Questo campo è fatto di differenze, differenze come valore. Solo la cultura è in grado di trasformare le differenze da stress a risorsa, al dl là della nascita di una geografia degli studi nei media negli Stati Uniti, quel luogo che è quasi la scaturigine, come si diceva una volta, dei processi intellettuali in ambito della comunicazione.
Morin è stato un nostro professore visitatore. Ho avuto la fortuna di chiamarlo a Roma al mio Dipartimento. Ha sparso lezioni agli studenti e soprattutto ci ha portato a cena, che è stato uno degli insegnamenti più affascinanti per scoprire la sua personalità. Posso dire che lui è un professore della Sapienza ed anche se lo è stato per poco tempo ha lasciato il segno. Per noi è stato uno studioso interessante, forse il primo che ci ha dato una lezione, abbastanza stressante all’inizio, della vicenda di scienze della comunicazione, e già di per se ci ha eliminato un po’ di angustie disciplinari. Noi siamo nati come sociologi e ci siamo sentiti orgogliosamente sociologi.
Negli anni ‘90 abbiamo cominciato a capire che sentirsi troppo una comunità, senza rompere i confini, significava vivere l’accademia, ma non mettere al centro i problemi. Gli studiosi si dividono in due tipologie: quelli che preferiscono i propri paradigmi e quelli che mettono i paradigmi alla luce dei problemi che affrontano.
La comunicazione è un problema talmente complesso, che pensare anche solo in astratto che solo la sociologia la possa interpretare, significa rinunciarla a capirla. La nascita del nuovo corso di scienze della comunicazione ci ha creato uno stress straordinario. All’inizio di questa vicenda, anche se solo per un breve periodo, apparentemente per un breve periodo, c’e’ stato Morin con la sua lezione di universalismo rinascimentale. Noi sappiamo che all’origine della nostra formazione culturale c’e’ stata questa idea dell’ intellettuale universale, di un periodo in cui si parlava della bottega rinascimentale. Questo signore è un perfetto maestro rinascimentale, proprio un uomo universale.
Tre parole chiave
A questo punto voglio darvi tre temi precisi di analisi del suo pensiero che possano offrirvi una chiave di lettura su quello che lui dirà sulla scuola, sull’università e sulla formazione. Negli ultimi tempi Morin si è occupato essenzialmente di tecnologie e di metodologie. Io la trasformo in una lezione che è più precisamente funzionale al lavoro che noi e voi dobbiamo svolgere oggi: “come il soggetto conosce il mondo”.
Pensate a quanto è provocatoriamente banale questa frase! Questa si riferisce a come avviene oggi, nelle nuove condizioni della comunicazione, la conoscenza, lo stoccaggio delle esperienze del mondo, quell’incredibile apparato simbolico. Oggi tutto questo va praticamente cambiato. Noi abbiamo poche lezioni su ciò. Anche il fatto di inseguire bene queste trasformazioni, anche della complessità, dell’approccio alla conoscenza, l’esperienza della conoscenza, non della messa in scena, ma dei modi concreti con i quali conosciamo, tocchiamo e percepiamo il mondo. Su questo abbiamo poche lezioni ma qualcosa c’e’ a portata di mano. Come il soggetto conosce il mondo, come possiamo dire ciò che diciamo, quali sono le condizioni di legittimità del nostro dire in pubblico. Si torna così agli elementi fondativi di essere una comunità, di essere persone in grado di scambiarci messaggi sensati e riconoscibili. Ancora, in riferimento alle istituzioni, ci sono abitanti e cittadini: gli abitanti di un territorio quando ne percepiscono il carisma,il vincolo, il motivo, il significato, quando cioè abitano cognitivamente ed emotivamente il proprio luogo. Sperlonga può essere un posto adatto sul quale applicare questo meccanismo per cui chi vi abita sente di abitarvi, è solo quel sentire elaborato culturalmente che trasforma un’esperienza apparentemente impalpabile ed effimera in un rapporto profondo, vincolante, come se un territorio venisse rivissuto nel cuore e nella testa.
La seconda parola chiave, forse un po’ estranea al pensiero da me promosso è l’autoriflessione. Questa è una delle parole chiave su cui il pensiero contemporaneo si sta più interrogando. Dietro c’è poco di paradigma, c’è però l’idea che in questo processo di radicale cambiamento, noi abbiamo solo un elemento di radicale stabilità che è il soggetto. Ancora una volta il soggetto che conosce, che deve essere ispirato, stimolato dal sistema produttivo, che deve essere messo nelle condizioni di diventare competente a conoscere. Anche qui sul concetto di autoriflessione c’è un margine importante per il territorio, per le differenze, per la scoperta e la piena valorizzazione delle differenze. Senza riflessione su noi stessi, noi cessiamo di essere uomini, e questo è tanto più vero nel primo tempo in cui la conoscenza è possibile per tutti. Nelle società del passato la conoscenza era selettiva ed autoritaria. Oggi la conoscenza rischia di diventare una risorsa quasi universale. Parliamo di un mondo in cui ciò è possibile, sappiamo che c’è un altro mondo in cui parlare di conoscenza è un messaggio vagamente spiritualistico ed inefficace. Ma noi pensiamo che anche qui si possa portare un messaggio in cui la conoscenza sia una risposta sempre più universale. La terza parola è: complessità. Ormai quando pensiamo a Morin inevitabilmente gli abbiniamo questo sostantivo, come quando a Leopardi abbiniamo pessimismo. La complessità è un paradigma elaborato e sofisticato. Io ne prendo i significati apparentemente più triviali e cioè complessità anche come complicazione, come aumento delle variabili da tenere in gioco. Tutte cose che possono agire sulla lettura del territorio. Di fronte all’aumento impressionante delle variabili e quindi di fronte allo stress della conoscenza, questa diventa tutt’altro che semplificata nella vita moderna dove tutto concorre ad aumentare l’opacità del mondo. Pensate a quanto è forte la responsabilità della conoscenza e della comunicazione che dovrebbe lottare per ridurre l’opacità del mondo. Noi abbiamo due sole possibilità d’uscita di fronte alla complessità come esperienza di vita, prima ancora che come paradigma scientifico. La prima possibilità è il ripiegamento: gli esseri umani sono veramente incoraggiati al ripiegamento, al ritiro. Pensiamo a quanto gli intellettuali del nostro tempo sembrano in ritirata rispetto all’aumento delle sfide ed alla complessità. La seconda possibilità è la sfida: non chiudersi in casa o comunque non chiudersi nel privato. Anche quello che noi chiamiamo egoismo è una metafora falsa, perché anche l’egoismo per potersi esercitare ha bisogno degli altri. L’egoismo per nostra fortuna non è concettualmente possibile. Io insisto nel dire che al di là del paradigma di Morin, di fronte a questo bivio dobbiamo scegliere ed imboccare una delle possibili alternative. Questa è la differenza tra l’autoriflessione ed il vivere passivamente, come se non si stesse vivendo.
La cultura è l’elemento che fa la differenza. La cultura, quindi l’università che non sta dentro le città, nel senso che si mettono in scena diversamente che in passato: non aspettiamo qualcuno che ci venga a cercare, ma andiamo lì dove il territorio ha bisogno di lettura. In questo pensiero incredibilmente umanista, di cui Morin è il portatore, pieno di interpretazione del cambiamento, questa sfida porta a dare della cultura il nostro punto d’incontro, come terziarietà rispetto agli antagonisti della politica, la politica che inevitabilmente ci divide. Noi abbiamo bisogno di trovare dei punti in cui ci scambiamo dei messaggi completi, esaurienti, plausibili prima ancora che ci dividiamo su problemi di società. Il luogo della cultura è un luogo che noi rivendichiamo orgogliosamente come uno dei nostro spazi di primato, non perché pensiamo che le amministrazioni e gli altri soggetti non lo facciano, ma perché l’università è stata inventata per questo. Non c’è nessun altro motivo che giustifichi la sopravvivenza dell’università, se non il fatto della nostra cultura. Se non ci ricordiamo questo non capiamo nulla di ciò che noi chiamiamo tradizione culturale, identità culturale, lasciando la parola tradizione e la parola identità all’interpretazione, come fosse roba da soffitta. Dobbiamo ricordarci che noi senza la nostra tradizione non siamo nulla. L’impegno di Sperlonga
Noi raccogliamo per intero questa sfida, che ci viene presentata. Siamo grati di essere in questo posto così spettacolare. Parlavano chiaramente le immagini del filmato, tanto che non c’era bisogno di commento sonoro, solo la musica faceva un po’ da controcampo alle immagini. Ma forse perfino muto, quel filmato sarebbe stato perfetto. L’impegno di Sperlonga è l’inizio di un percorso o comunque la continuazione di un nostro percorso biografico in cui il racconto dei successi e dei problemi è il modo con cui ognuno di noi riflette sul segno che vuole lasciare al territorio. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di essere quelli che hanno conosciuto Morin, perché conoscere una persona è diverso che leggerla, significa conoscerla più in profondità, al di là delle parole, c’è qualcosa tra persona e parole che è un miracolo che bisogna cogliere.
Immagini scelte per voi:

NB : Cliccate sull'immagine desiderata per visualizzarla nelle dimensioni reali.
top
|
 |
Allegati |
 |
|
|
|
|